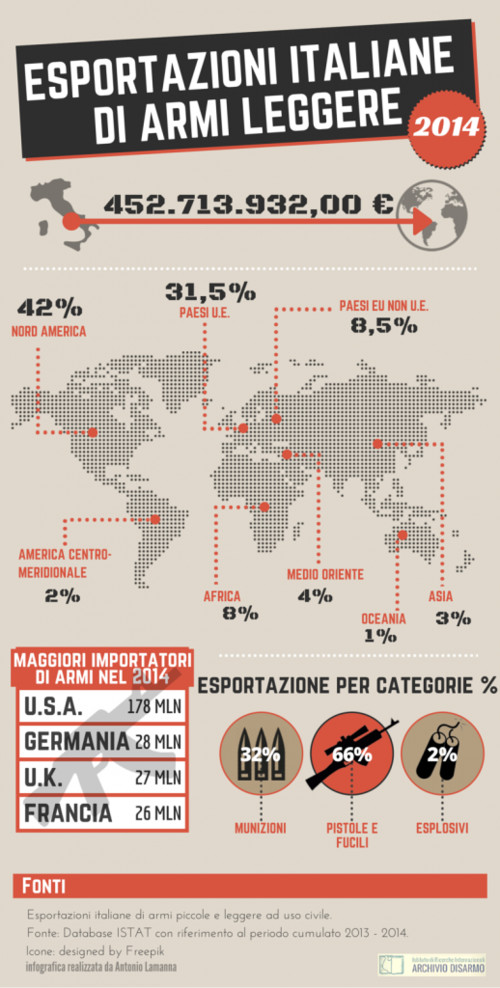Un contributo diretto al fondo di risarcimento per i familiari delle vittime e per i sopravvissuti dell’incendio alla fabbrica Tazreen di Dhaka in Bangladesh. È la richiesta avanzata dalla Clean Clothes Campaign,presente in Italia con la sua sezione Campagna Abiti Puliti, e dal Labor Rights Forum ai clienti internazionali della fabbrica come l’americana

Laboratorio tessile bruciato in un incendio. Fonte: rapporto H&M in Bangladesh, Clean Clothes Campaign, ottobre 2015
Walmart, la sezione spagnola de El Corte Ingles, il distributore tedesco KIK, C&A e Sean John’s Enyce brand, oltre ad altri marchi collegati come Edinburgh Woollen Mill (UK), KarlRieker (Germania), Teddy Smith (Francia), le americane Disney, Sears, Dickies e Delta Apparel e l’italiana Piazza Italia.
L’appello, ribadito con una nota diffusa ieri, arriva alla vigilia del terzo anniversario del disastro (24 novembre 2012) costato la vita a 112 persone. “Quando divampò l’incendio, i lavoratori restarono intrappolati nella fabbrica: le uscite erano bloccate e l’unico modo per scappare era buttarsi dalle finestre dei piani alti” ricordano i promotori della campagna. “Più di cento lavoratori rimasero feriti saltando da quelle finestre al terzo e quarto piano, con lesioni alla schiena e alla testa che hanno causato molto dolore”.
Un accordo per coprire la perdita di reddito e le spese mediche è stato siglato lo scorso anno da IndustriALL Global Union, la Clean Clothes Campaign, C&A e la C&A Foundation. L’intesa, ricorda la nota, “ha portato alla creazione del Tazreen Claims Administration Trust, che sovrintende il processo per le richieste di rimborso, collabora con le organizzazioni che rappresentano le famiglie e raccoglie fondi per effettuare i pagamenti. Le famiglie degli operai morti nel rogo hanno cominciato a registrare le loro richieste e oggi il Trust ha lanciato un nuovo sito web (http://tazreenclaimstrust.org), che fornisce informazioni sul processo e dettagli su come possono essere effettuate le donazioni”.
Gli attivisti hanno chiesto da tempo ai marchi con un fatturato di oltre 1 milione di dollari di versare almeno 100 mila dollari nel Trust Fund. “C&A e Li & Fung (che si riforniva per conto di Sean Paul) si sono già impegnate ad effettuare versamenti” ricorda la nota. “La tedesca KiK, attualmente coinvolta in una controversia per quanto riguarda il suo rifiuto di negoziare il risarcimento delle vittime dell’incendio alla Ali Enterprises, ha ora accettato di effettuare un versamento”.
Ma l’impegno, al momento, non è stato condiviso da tutti. “Il più grande cliente della Tazreen, Walmart, non ha ancora corrisposto un centesimo per le vittime e i loro familiari. Eppure nel 2014 aveva dichiarato pubblicamente la volontà di voler contribuire con 3 milioni di dollari attraverso la BRAC USA per le vittime del Rana Plaza e di altre tragedie dell’industria tessile del Bangladesh. 1 milione di dollari lo ha versato nel Rana Plaza Trust Fund, 92 mila dollari li ha forniti per le cure mediche. Cosa intende fare con il restante 1,1 milione di dollari promesso?”. Ad oggi, osservano ancora gli attivisti, “anche le intenzioni della sezione spagnola del El Corte Ingles non sono chiare, visto che, pur avendo partecipato al Comitato iniziale incaricato di portare avanti il processo sul Rana Plaza, non si è ancora impegnato per nulla sul caso Tazreen”.
Proprio i mancati contributi, unitamente alla scarsa attività di prevenzione e controllo sulle condizioni dei lavoratori della catena di fornitura, evidenzierebbero secondo gli attivisti il persistente problema di una sostanziale carenza regolamentare. Un argomento, quest’ultimo, che sarà al centro dell’incontro del prossimo 21 novembre a Torino (qui il programma) quando, nella cornice dell’ex Birrificio Metzger (via Bogetto 4/g, inizio del dibattito alle ore 10:30), attivisti, esperti del settore e istituzioni discuteranno sulle strategie e gli strumenti utili “per proteggere in maniera più efficiente ed efficace i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici nel mondo”.
Fonte: valori.it – 18-11-2015
http://www.valori.it/economia-solidale/tazreen-e-le-multinazionali-che-non-pagano-10758.html